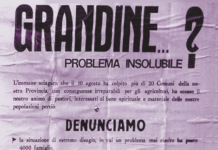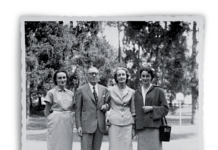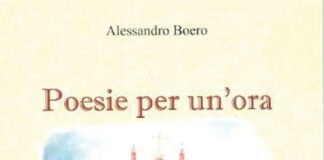In questi anni di centenario della Grande Guerra, numerose mostre esibiscono spesso lettere e diari scritti dai soldati al fronte. Scrivere a casa, pur con la fatica tipica di chi era quasi illetterato, significava evadere da un mondo indecifrabile e terribile per rifugiarsi in quello domestico carico di senso e di affetti. Registrare, con un mozzicone di matita e un taccuino di fortuna, gli spostamenti, i nomi dei luoghi e dei monti, gli accadimenti principali, acquistava un significato speciale: un gesto che doveva assicurare una sopravvivenza virtuale di fronte alla morte incombente. Più che nelle lettere – dove i soldati rassicurano i familiari della loro “buona salute” ed evitano, per comprensibili ragioni, di rappresentare lo scenario degli stenti – è nei diari che si parla di cibo. In modo particolare la fame e l’ossessione per il “mangiare” emerge nei diari dei prigionieri di guerra nei campi austriaci e tedeschi, molti dei quali riutilizzati come luoghi di internamento nel corso del secondo conflitto mondiale.
«Ci danno da mangiare ogni mattina tre reghe [aringhe, ndr] con vermi e brodi di farina amara». «Riceviamo un’arringa per uno la sera con tre o quattro pezzetti di patate o carote e un mescolo di acqua calda».
Le testimonianze (queste sono tratte dal saggio Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra di Giovanna Procacci, Bollati Boringhieri) concordano, con qualche minima variante (talora caffè d’orzo, zuppa di barbabietole, acqua calda e rape) e si soffermano tutte sul razionamento del pane. Ne parla nel suo Giornale di guerra e di prigionia anche Carlo Emilio Gadda che, nonostante fosse meglio trattato in quanto ufficiale, annota: «Trangugiavo, divoratolo a morsi, l’esiguo pane: la solita fetta, un quinto, impastata di castagne d’India, dicevano, e poi di tritume della paglia, forse di sègale. Questo quinto risultava da una divisione meticolosa della pagnotta; le cinque porzioni, tagliando, si misuravano per successivi confronti, cubandole al millimetro, soppesandole al grammo».
La parcellizzazione delle pagnotte, suddivise tra un numero di prigionieri variabile, anticipa un’esperienza ripropostasi nei campi di internamento della seconda guerra mondiale.

Come testimonia il diario di un ex deportato militare astigiano, Giuseppe Bombara, catturato dai tedeschi a Sebenico, in Dalmazia, appena dopo l’Armistizio dell’8 settembre.
Dopo un viaggio allucinante durato dieci giorni, alcuni dei quali senza mangiare, viene rinchiuso in un campo tra Berlino e Amburgo. Giuseppe annota con precisione il rancio giornaliero: «due fette di pane con margarina…»; «minestra di ghiande…»; «un ettogrammo di patate…»; «minestra di verze con brodo che non è altro che acqua…». Qualche volta caffè, un cucchiaio di marmellata o una fetta di salame.
Poi il lavoro, una via crucis lunga 12 ore: un lavoro disumano, sproporzionato alle forze fisiche degli internati, debilitati dalla denutrizione e dalle malattie. La Germania nazista non li riconobbe come prigionieri di guerra e, per poterli sfruttare senza controlli, li classificò come “internati militari italiani” (IMI), categoria ignorata dalla Convezione di Ginevra. Per entrambi i conflitti le cifre non sono troppo dissimili: su circa 600 mila prigionieri militari italiani, 100 mila non tornarono più al termine della Grande Guerra; i deceduti nei campi di prigionia della Seconda furono almeno 45 mila. Per sopravvivere, si ruba con enormi rischi qualche patata, ci si avventa sulle bucce degli ortaggi, si vendono gli indumenti per un’ulteriore razione di pane. E si sogna. I prigionieri della Grande Guerra pregustano i fagioli e le castagne secche, il riso e lo zucchero che forse arriveranno con i “pacchi” richiesti ai familiari tramite la Croce Rossa, come racconta con dovizia di particolari Augusto Monti, lo scrittore e professore originario di Monastero Bormida nel suo epistolario con la prima moglie, da giovane sottotenente prigioniero degli austriaci.

Cibi che riempiano la pancia, che ormai “tocca il filo della schiena!”, come scrive Meo Gonella di San Martino Alfieri. Qualcuno, con uno slancio di fantasia figlia della fame e della disperazione, architetta incredibili libri di ricette. Sono stati pubblicati in un unico volume dal titolo La fame e la memoria. Ricettari della grande guerra, Cellelager 1917-1918, Agorà Libreria Editrice. Ne sono stati artefici i sottotenenti Giuseppe Chioni (ligure) e Giosuè Fiorentino (siciliano) che, raccolte presso i commilitoni le ricette di casa, le trascrissero in quadernetti, abbellite con disegni e svolazzi grafici, come nella copertina disegnata da Chioni, che recita “Arte culinaria”. Ne risulta un’ampia scelta di specialità regionali (circa 400) che spaziano dal nord al sud dell’Italia. Predominano – e non è un caso – piatti ricchi di grassi e condimenti, ma sono descritti anche dolci, conserve, tipi di pane: morbidi panini bianchi definiti “viennesi” e pani arricchiti di fichi e di noci. Una sorta di sogno a occhi aperti, un paradiso gastronomico che i rinchiusi immaginano e rincorrono come il mitico paese di Cuccagna. Un posto che nella radicata tradizione popolare non rappresenta soltanto il luogo dove è possibile mangiare e bere a dismisura, ma un mondo capovolto rispetto alla condizione che si sta vivendo.