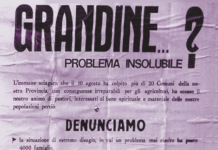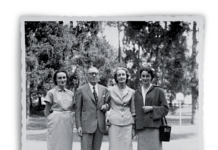Oggi ci sono le vinerie e i wine-bar, ma le vecchie osterie erano un’altra cosa. Ambienti chiusi, fumosi, frequentati per lo più da gente del popolo, carrettieri, facchini, fabbri, falegnami. Qualcuna aveva anche camere per i forestieri e il servizio di stallaggio.
Avevano sopra l’ingresso una luce che fungeva quasi da faro e richiamo perché potesse orientare chi non era già più sobrio. Al bancone si sostava pochi minuti a bere un bicchiere di vino (sempre servito stracolmo) e la sala con tavoli dalle gambe tornite e sedie impagliate ospitava chi voleva passare la sera o la domenica pomeriggio a chiacchierare, a cantare, a giocare a scopa o ai tarocchi.

Ai suoi tavoli si ritrovava una fauna umana variegata, soprattutto al maschile. L’osteria, infatti, con la piazza e la chiesa è stata un importante luogo di socializzazione.
Uno dei ritrovi dove ci si incontrava liberamente.
Sotto questo punto di vista, quindi, l’osteria – proprio perché difficilmente controllabile nelle sue manifestazioni di trasgressione e di sovvertimento dell’ordine religioso e civile – diventava una sorta di “antichiesa”. Basti ricordare l’ironico testamento di Giacu Trùss che tra l’altro indica minuziosamente la ritualità della sua sepoltura nell’osteria, utilizzando come vasi sacri i «quartìn, pinte e bucàj» della taverna e come canti sacri gli sguaiati cori degli ubriachi.
Il vino era il comun denominatore delle osterie. Venduto sfuso e qualche volta anche “da asporto”, non sempre era buono. Sulla scadente qualità dei vini proposti dagli osti storia e leggende si confondono: si potrebbero citare “La tampa nera” a San Rocco, dove si diceva che un avventore ordinò un bicchiere di vino, non lo bevve, ma vi intinse il coltello solo «per avvelenarne la punta».

Molte osterie avevano la cucina che serviva cibi “robusti” come gorgonzola, burro e acciughe, bagnet. Celebri furono per una decina d’anni i “corrosivi” agnolotti con il bagnetto rosso “da Scaglione” in via Quintino Sella. Gli avventori delle osterie molte volte oltrepassavano i limiti, si ubriacavano e di lì in poi iniziavano la “commedia”. E cumèdia era appunto uno dei nomi che nel gergo astigiano si dava alla bottiglia di vino. Qualcuno aveva “il vino cattivo” e spesso doveva essere allontanato a forza dall’oste. Spesso iniziavano cori che riproponevano le canzoni più classiche, dai canti alpini, ai brani popolari, ai motivi del Festival di San Remo, dei quali venivano storpiate le parole.
Un “classico” degli Anni ’50 era «vola pulènta e bergunzòla» sul motivo di «vola colomba bianca vola». Si cantava, ma ancor di più, tra una discussione e l’altra, si giocava a carte. In genere erano sempre di scena i tarocchi, la scopa e il tresette. I punti si segnavano spesso con il gessetto su una piccola lavagna, di quelle con una cornicetta di legno, che si cancellava con una zampa di lepre, o di coniglio, come portafortuna.
Non mancavano le discussioni che crescevano di tono e si facevano sempre più accese sugli argomenti più vari, dallo sport alle notizie tratte dai giornali, e si finiva sovente in politica. Alterchi a volte così violenti che i governanti, nei secoli, tentarono di frenare. Negli Statuti di Asti del 1379, che regolavano dettagliatamente la vita in città, troviamo infatti norme severe che stabilivano che tutti i tavernieri fossero tenuti a prestare giuramento impegnandosi a non dare ospitalità a banditi o delinquenti, a non somministrare cibi o bevande dopo il tocco della campana della “compìeta” nella tarda serata, a non vendere o somministrare cibi in luoghi diversi, a non permettere che si giocasse d’azzardo. Pena la multa di 3 lire astesi. Doveva pagare 20 soldi chi era sorpreso a bere e mangiare dopo l’ora stabilita. E chi non era in grado di pagare la penale veniva “messo al bando” fino al saldo del dovuto.

Minuziose anche le disposizioni nel periodo napoleonico, tanto che dopo le ore “undici di Francia della notte” non era permesso dare ricovero, né da bere, né da mangiare e si dovevano chiudere le porte delle osterie, botteghe o caffè, sotto pena di 2 scudi.
I nomi delle osterie erano tipici e curiosi, anche se è scarsa la documentazione per i secoli più remoti. Del Quattrocento si conoscono, tra le altre osterie astigiane, quelle del Pesce, del Montone, del Moro, il San Giorgio, la Croce Bianca, la Corona.
Nell’Opera Jucunda di Giovan Giorgio Alione, pubblicata nel 1521 in dialetto astigiano, incontriamo quella di Freigiurìn (freddoloso), dove si mangiava «cappon, trippa e pan frèsch» o, come nella farsa del “Franzoso”, “l’ostaria del Lombardo”.
E poi, nel Seicento, le Tre Trombe, la Luna, San Francesco, dell’Aquila, della Poma, della Rosa Rossa, del Moro, di San Paolo, quella dell’hoste Reynero detto il Sordo, Le Due Chiavi, della Croce d’Oro, Tre Spade, del Cordaro, della Forgia e della Fontana.

Nel Novecento erano ancora attivi una settantina di “ostu”
È del 2006 un nostro “censimento” delle ultime osterie della città, quelle del Novecento, prima che svanissero anche dalla memoria, pubblicato sul Codice della cucina autentica di Asti (Sagittario editore). Ne sono state ricordate una settantina. Di quei tanti òstu attivi in città, almeno qualcuno tra i più rinomati e frequentati merita un breve ricordo.
Uno degli ultimi, la Trattoria del Mercato, chiuse, non senza polemiche, nel 2000 quando fu demolito il basso fabbricato che la ospitava in piazza del Palio, quasi all’angolo con via Emanuele Filiberto. Un locale storico, uno stanzone e una stufa, rilevato nel ’48 dalla famiglia di Rosalba Faussone, dove a mangiare trippa, merluzzo, fritto misto, agnolotti si alternarono generazioni di astigiani delle estrazioni più diverse e dove già alle prime luci del mattino i negozianti del mercato si concedevano robuste colazioni. La mitica Rosalba servì i suoi piatti anche a scrittori come Luis Sepùlveda, che la citò in un suo racconto, e ospitò la torcida giornalistica al seguito del Brasile ai mondiali di calcio del 1990, quado la nazionale carioca venne in ritiro ad Asti. Dopo la chiusura Rosalba continua ad aiutare il nipote nella trattoria che porta lo stesso nome, dall’altro lato della piazza.

Entrando al Falcon Vecchio, c’era un tavolino di ferro rotondo sul quale erano sempre appoggiate bottiglie di vino che sull’etichetta avevano dei segni fatti a matita, ma nessuno se ne stupiva. Erano le bottiglie dei clienti abituali. Falegnami, materassai, bottegai, che a metà pomeriggio sospendevano il loro lavoro per la “pausa bevuta”. Lasciavano la loro bottega nei dintorni e si ritrovavano alla “Falca”. Sulla bottiglia che non veniva finita il giorno era “segnato” il livello del vino, in modo da essere sicuri che il giorno dopo si ritrovasse allo stesso livello e che nessuno nel frattempo ne avesse approfittato. Nel 1753 si trasferì dall’attuale via Gobetti alla via dietro la Collegiata. Per gran parte del secolo scorso fu gestito da Giovanni Chiusano (che molti ricordano in tarda età ancora a compiere il rito del taglio dei bolliti ai tavoli dei clienti) e dalle figlie Adelina e Jucci.
Il Caffè San Carlo, ancora oggi come in passato, è il ritrovo dei trifulau che già nelle prime ore del mattino segnano la loro presenza con l’inconfondibile profumo dei tartufi. Tra le due guerre il lato destro del locale, verso via Repubblica Astese, al sabato sera e alla domenica, diventava abitualmente “café-chantant”. Il San Carlo era posto di commercio. Tra gli abituali clienti anche diversi pastori, solitamente accampati sulle rive del Tanaro, che andavano a vendere le loro tome.
Il Macallè, chiuso nell’ottobre 1965, durante l’ultima guerra ha avuto un ruolo di non secondaria importanza nella lotta partigiana. Flavio Tosetti – proprietario del Macallè con la moglie e i figli Angelo, partigiano, Libero e Nanni – fu un grande antifascista e il suo locale fu a lungo un ritrovo clandestino durante la lotta per la liberazione, frequentato da Pietro Berruti, dal “colonnello” Toselli, da “Berto” e da altri capi partigiani. Al tempo stesso, però, ai tavoli del Macallè sedevano sovente a cena il comandante del presidio tedesco con altri ufficiali. E addirittura si dice anche che tra il cuscino e la sedia dove Flavio Tosetti sedeva abitualmente dietro il bancone fosse nascosto un quaderno dove venivano segnati messaggi e movimenti delle bande partigiane. Di sicuro, nella grande cantina sotto il Macallè c’erano mitra, pistole e bombe a mano, destinate ai partigiani, ben nascoste nelle botti.
Nel 2000 chiuse la Trattoria del Mercato che ispirò un racconto di Luis Sepùlveda
La Ciòrnia vèrda si affacciava su piazza San Giuseppe. Era bottiglieria e trattoria dove la “Néta” era addetta alla cucina. Chiuse intorno al 1960. Ufficialmente non aveva un nome. Qualcuno sostiene che ciòrnia vèrda derivasse dal fatto che la padrona, la figlia e addirittura la nipote fossero piuttosto sorde e che tutte e tre amassero vestire sempre con qualcosa di verde, al punto che per un certo periodo anche le pareti del locale furono tinteggiate di verde. Ma c’è anche da tenere conto che ciòrnia vèrda è il nome che nel gergo astigiano era dato alla gorgonzola, uno dei cibi più richiesti nelle osterie.
Tra i piatti più serviti, oltre alla gorgonzola, c’erano le alborelle del Tanaro in carpione. Erano fritte e “scarpionate” in continuazione e sempre aggiunte a quelle solitamente contenute nella bertùn-a, il grande piatto fondo di terracotta che non veniva mai svuotato, così che gli avventori non sapevano se mangiavano quelle cucinate il mattino stesso o quelle di quindici giorni prima.
La “Ciòrnia vèrda” era il ritrovo dei cartuné che dal Borbore portavano la sabbia ai muratori nei cantieri e si fermavano a berne un bicchiere a ogni passaggio. Si ritrovavano anche il sabato pomeriggio per aggiustare i conti con i loro clienti. Si usava un sistema molto semplice ma ingegnoso, che non lasciava adito a discussioni e contestazioni. Per tenere la contabilità si utilizzavano due strette e sottili assicelle di legno lunghe una spanna. Una la teneva il carrettiere e una il capomastro. Alla consegna in cantiere di ogni tumbarèl di sabbia o ghiaia, i due estraevano di tasca le tavolette di legno, le affiancavano, vi incidevano una tacca con un coltello che passava su entrambe e poi ognuno si riprendeva la sua. Quando a fine settimana ci si trovava davanti a una bottiglia per regolare i pagamenti, il confronto dei due pezzi di legno non ammetteva discussioni.

Di fronte alla chiesa di Santa Caterina, accanto all’antica Porta Sant’Antonio, c’era l’osteria di Trej Ciuchìn documentata dagli inizi del ‘700. Fu il teatro delle gesta epiche di Filippo Righetti detto “Falamoca” (omonima maschera del carnevale astigiano) che, di guardia alla Porta, uccise tale Ottavianino, rifiutatosi di “reggere la pietra” in segno di pedaggio, ma poi assolto per aver difeso la sicurezza della città. Quell’osteria era un punto di sosta quasi obbligato per chi tornava da un funerale. Tornando dal cimitero, gli amici del morto si fermavano a bere una bottiglia di vino e poi se ne andavano lasciando sul tavolo un bicchiere pieno, per il defunto.
Nel cuore di Asti, in vicolo Anfossi, c’era la Trattoria del Popolo. Più conosciuta ancora come “Il Popolo”, è stata attiva per quasi tutto il Novecento e per lunghi decenni la gestì Albino Freilino con la sua famiglia. Un pilastro di ghisa al centro di una sala abbastanza grande da contenere il bancone di legno con dietro la stagera piena di bottiglie, lo spazio per gli avventori che si accontentavano di un bicchiere bevuto in piedi con qualche veloce commento, e un buon numero di tavoli “da ostu”, cioè quelli abbastanza lunghi e piuttosto stretti, con le gambe tornite. Il Popolo – che del resto rispettava le regole e le usanze di tutte le altre osterie della città – si animava a metà pomeriggio, dopo le quattro, quando comparivano gli artigiani e i bottegai dei dintorni. A cena, qualcuno c’era sempre. Sapeva che Rita (la “Bina”) aveva pronta pasta e fagioli, oppure i ceci con le costine se era stagione, o in alternativa una pastasciutta, mentre gli agnolotti venivano fatti, rigorosamente a mano, solo su richiesta o nei giorni di festa. Non mancava mai l’arrosto con più di un bagnet, o la trippa in umido o lo spezzatino. Dopo cena ai tavoli i soliti clienti intavolavano le solite discussioni, animate fino a tarda ora, quando sulla porta si “mettevano le ante” e si spegneva lo sferico lampioncino opaco che illuminava fioco l’ingresso.
Un rito che si è compiuto per decenni. Poi arrivarono i bar, le insegne al neon e le prime televisioni. Il mondo stava cambiando e anche il tempo delle vecchie osterie è svanito.
Le schede