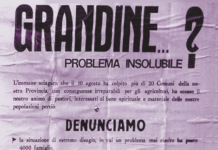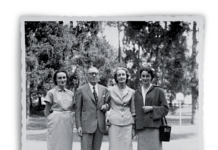Gli inverni non sono più quelli di una volta. È anche cambiato il modo di proteggersi dal freddo.
Tessuti “tecnologici”, piumini “cento grammi” hanno lasciato nei guardaroba i pesanti cappotti. Ancor più antico e suggestivo il mantello.
Nelle campagne astigiane veniva indossato dagli uomini, per ripararsi da freddo, pioggia e neve, accompagnato dal cappello a tesa larga. Nei guardaroba di molte famiglie e sui mercatini dell’usato ci sono ancora i tabarri grigio-verdi utilizzati dal Regio Esercito nella Prima guerra mondiale.
La mantella in Piemonte ha identificato per anni i tartufai (trifolau) e i commercianti di bestiame. Carlin Petrini, e prima di lui Luigi Veronelli, ha adottato il tabarro nero come simbolo di un certo mondo contadino.
Lo si può incontrare alla fiera del bue grasso di Carrù e, oltre a indossarlo con i suoi amici, ha voluto che l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo dotasse gli studenti di tabarro nel giorno della consegna delle lauree.

Un antenato del cappotto è la marsina (soprabito francese, sovente ricamato), da cui nasce l’inglese riding-coat (diffuso in Europa come redingote), un cappotto da gentleman.
Da questi modelli si svilupparono molte varianti: il carrik (con mantellina, pensato per i viaggi); il paletot o paltò (in voga nell’800 e nei primi decenni del Novecento); il modello raglan (con spalle dal taglio obliquo, prende il nome da Lord Raglan, comandante delle truppe britanniche nella Guerra di Crimea).
Dalle nostre parti il paltò era anche una sorta di premio per i bacialè ovvero i “mediatori di matrimoni” che, un po’ per diletto e un po’ per mestiere, facevano in modo di trovare spose ai giovani di campagna. A matrimonio avvenuto al bacialé andava come compenso un paltò o l’equivalente in stoffa per farlo cucire su misura dal sarto.