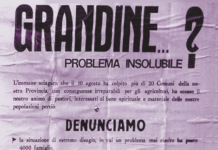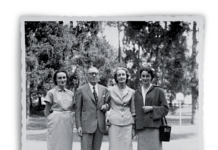Immaginiamo una piccola proprietà contadina o un podere mezzadrile – la mezzadria fu abolita per legge solo nel 1964, mantenendo tuttavia i contratti già in corso – nel secondo dopoguerra. Immaginiamo una famiglia con terreni a coltivazioni specializzate e residue porzioni a colture miste, utili a integrare il fabbisogno quotidiano. Un piccolo appezzamento di vigneto poteva avere anche una coltura consociata temporanea – scelta rafforzata per necessità nel periodo bellico – con interfilari di leguminose e di patate, mentre nel campo giù a valle i fagioli di Spagna e quelli del Papa (grossi, piatti, con screziature di vari colori) si arrampicano sulle piante di granoturco.
Qua e là spuntano alberi da frutto. Nonostante si sia alla vigilia del boom economico e di un nuovo stile di approvvigionamenti e consumi, è molto probabile che questa famiglia non si sia sottratta all’uso di fare scorta, attingendo alle stagioni adatte, di prodotti da conservare per il periodo invernale. Lo ricordano le nonne di oggi che, in quegli anni, erano ragazze. Ricordi vividi, inframmezzati da sorrisi e da qualche rimpianto, ma quasi sempre sostenuto dall’orgoglio di aver vissuto esperienze irripetibili, di aver partecipato a riti scomparsi, di aver mangiato ghiottonerie mai più viste. Tutte home made, cioè rigorosamente fatte in casa.
Come le ciapùle, fette di frutta seccate al sole estivo e conservate in sacchetti di tela. Erano per lo più albicocche tardive o pesche gialle, possibilmente piccole e asciutte di polpa: si spaccavano a metà senza sbucciarle e le si esponeva su graticci sui balconi più soleggiati e ariosi, ritirandole alla sera. La buccia pelosetta dei frutti raspava un pochino il palato e allegava i denti, ma erano una bontà. Niente a che fare con le albicocche disidratate di oggi della Noberasco e di altre di marche, gustose sì, ma un po’ mollicce.
Anche le piccole prugne andavano bene in queste pratiche di essiccamento naturale, mentre con i fichi era più difficile, non abbiamo il sole cocente del Sud o della Turchia, meglio cuocerli con zucchero e aceto e metterli nelle burnìe con il loro sciroppo. Per le pesche, poi, è durata a lungo la consuetudine di conservarle nelle bottiglie da vino di vetro scuro: un lavoro certosino per tagliarle a fettine – le più usate erano le pesche di vigna, con varietà dalla polpa attaccata al nocciolo – e poi per estrarle al momento del consumo. Ma che sapore!

Per non parlare dei pum smujà, le mele conservate in un liquido acidulato. Si prelevavano direttamente dalla damigiana a collo largo, come del resto i peperoni a tumatica che riposavano sotto le raspe. Se i puvrùn smujà in semplice soluzione di aceto, sale e acqua o fra strati di vinacce appartengono al nostro presente e sono menzionati tra i prodotti tipici astigiani, con particolare riferimento al piccolo eccellente peperone di Capriglio, le testimonianze relative ai pum smujà – per lo meno fra quelle ritrovate in città – si collegano alle feste patronali a cavallo dell’ultima guerra: «Quando si veniva a Sansgund, mio papà comprava a noi bambini un cartoccio di pum smujà. Li prendevano da un grande mastello… erano freschi e pizzicavano in bocca (frisìvu)».
In verità, il più recente ricordo, quello di Aldo classe 1956, è un’immagine nitida di piazza Catena e di alcune contadine che vendevano questa specialità, povera e curiosa, fino agli inizi degli anni Sessanta. A fine inverno la dispensa dei nostri contadini cominciava a essere sguarnita. Come frutta, gli ultimi grappoli di uva fragola o moscato d’Amburgo messi ad appassire in un posto fresco e arieggiato, e l’ultima provvista di mele: marcun, carpendù, rusnent, ormai un po’ raggrinziti, erano buoni da cuocere o per fare una torta.
Qualche manciata di biscöcc, una quintessenza del sapore di castagna, ottenuti dai frutti prima lessati e poi seccati in forno: e qui il ricordo si protrae – almeno per le generazioni degli anni Cinquanta – associato alla frutta secca dei giorni di Natale e Capodanno. Nei sacchetti di tela ci sono ancora fagioli secchi, e con i bianchi di Spagna si fanno a fine inverno buone insalate con l’aringa e le cipolle, conservate al fresco perché non germoglino. I ceci sono finiti con le feste dei Santi, ma la quantità di borlotti basta per tante minestre ancora. La zuppa la si fa buona con un abbondante battuto di lardo – ecco un altro alimento che i nostri contadini che, guarda caso, hanno pure allevato un maiale, sono riusciti a conservare, con l’opportuna salagione, fino a fine febbraio – e la si fa diventare un piatto sontuoso con dei maltagliati impastati e tagliati a mano. Altri legumi? Non sono terre da lenticchie, le nostre.
La sorpresa delle fave
Vengono bene le fave, ma si deve aspettare la fine dell’inverno per seminarle e averle, tenere e fresche, tra maggio e giugno. Se è vero che Gian Luigi Bera in Codice della cucina autentica di Asti riferisce di una stupefacente sopravvivenza gastronomica nel Nord della provincia astigiana da farsi con le fave fresche bollite, ridotte in purè, quindi insaporite da un intingolo di cipolla e pancetta, ci piace immaginare la fava amnaja – questo il nome del piatto – preparata con le fave secche. Chissà se la nostra famiglia di contadini ci avrà mai pensato?
La Scheda