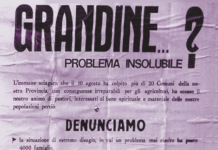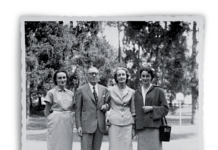Il seminario di Asti in una cartolina dei primi Anni ’30. Aveva un ingresso che si affacciava su piazza Catena
La Repubblica Sociale per costringere i giovani ad arruolarsi segregò le famiglie dei renitenti
Accadde settant’anni fa. Era il 24 dicembre 1943 quando in piazza Catena si radunò una folla silenziosa. Davanti al seminario, che all’epoca aveva uno degli ingressi proprio sulla piazza, centinaia di astigiani manifestavano il loro sostegno a 220 donne rinchiuse nell’edificio, controllato dalla Guardia Nazionale Repubblicana, la GNR, il braccio armato del regime fascista di Salò. Cosa stava succedendo? E perché, poche ore prima, il vescovo di Asti si era presentato alla porta del seminario con una valigia in mano?Per spiegarlo occorre un passo indietro di alcuni mesi. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, l’Italia viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia. La famiglia reale era fuggita a Brindisi, mentre l’esercito si trovava allo sbando, senza più ordini né direttive: 650mila militari italiani furono deportati in Germania; decine di migliaia, quelli più fortunati perché si trovavano vicini a casa, tornarono dalle loro famiglie. Altri ripararono verso il primo rifugio disponibile. A fine settembre si costituì formalmente la Repubblica Sociale Italiana: era il regime fascista che tentava di risollevarsi sotto il vigile controllo nazista. Mussolini fu messo alla guida di uno stato senza capitale: a Salò infatti avevano sede solo l’agenzia di stampa e il Ministero della Cultura Popolare, mentre gli altri dicasteri erano disseminati tra Verona e Brescia. Soprattutto, la Rsi doveva tentare di ridarsi un esercito. Il regime affidò al maresciallo Rodolfo Graziani, vecchio nemico del “traditore” Badoglio, la guida delle forze armate “repubblichine”. Tra le varie formazioni che avevano adottato sulle mostrine il gladio anziché le stellette c’erano il battaglione San Marco, che fu impiegato contro i “banditi partigiani”, la Guardia Nazionale Repubblicana, che aveva assorbito anche i carabinieri, e la Brigata Ettore Muti, che era invece la famigerata legione usata per i rastrellamenti e che prendeva il nome da un milite fascista ucciso dai partigiani. E poi c’era la Decima Mas del comandante Julio Valerio Borghese. Ad Asti Guardia Nazionale Repubblicana e Brigata Ettore Muti avevano trovato sede all’attuale casa di riposo, allora Istituto Umberto I.

Nei bandi di leva si minacciava l’arresto per i famigliari dei renitenti
Al primo bando di leva, emesso all’inizio di novembre e firmato da Graziani, furono in pochissimi a rispondere. «Avevano affisso manifesti che richiamavano a militare anche la nostra leva, quella del 1924, avevamo 19 anni», ricorda Giovanni Bosia, astigiano e in seguito partigiano tra San Marzanotto e Isola d’Asti. Il bando specificava chiaramente le conseguenze per i renitenti alla leva: per i famigliari di chi non si presentava era previsto l’arresto. Si trattava di metodi che i repubblichini avevano mutuato dall’alleato tedesco e ferocemente efficaci nel mantenere il controllo dei territori occupati. Nella seconda metà di quel novembre 1943, il metodo fu messo in pratica anche ad Asti. Le adesioni alla leva obbligatoria repubblichina languivano e si tentò di stanare i giovani colpendo le loro mamme.«Circa 220 donne astigiane – ricorda Bosia – vennero portate al seminario e sistemate nei locali del pian terreno, al freddo. Tra queste c’era anche mia madre, donna forte che mi fece anche da padre e carabiniere. Era lei che comandava al laboratorio di marmo che avevamo a Sessant». Anche le madri di alcuni celebri astigiani rimasero a lungo in seminario, tra cui quella del medico Aris d’Anelli e del calciatore dell’Asti Giuseppe Cavagnero. «Entrarono tutte in seminario passando dall’ingresso che allora si trovava in piazza Catena, a metà del palazzo, e che ora è murato. Le fecero dormire su pagliericci, e quando questi non bastavano, sulla paglia. Per pasto, un semplice rancio servito in gavette di metallo.»

Il destino di queste donne ostaggio corse parallelo a quello dei famigliari maschi dei renitenti. I padri e i fratelli più giovani di questi ultimi non vennero risparmiati dall’arresto e furono imprigionati al casermone Carlo Alberto, oggi in parte recuperato e sede dell’Istituto Monti. Per certi versi, la sorte dei famigliari maschi era ancora più preoccupante, perché il terrore costante era quello di vedere padri e fratelli deportati in Germania con il primo treno. L’intenzione dei fascisti era di costringere i ragazzi astigiani ad arruolarsi, facendoli uscire dai loro nascondigli in cambio della liberazione dei famigliari. Qualcuno cedette alla pena provata per i propri congiunti e si presentò: molti di quei ragazzi finirono tra le fila dell’esercito repubblichino, in Germania nei campi di internamento o a lavorare per la Todt, organizzazione tedesca di lavoro militarizzato che si occupava del ripristino dei danni causati dai bombardamenti alleati. Ma dal seminario di Asti, in quel dicembre 1943, furono 68 madri sulle oltre 200 imprigionate che fecero comunque sapere ai figli di non presentarsi all’arruolamento. I contatti con l’esterno non mancavano. Alcune potevano uscire di giorno con permessi speciali e anche ricevere delle visite; le comunicazioni con le prigioniere, ricorda Giovanni Bosia, avvenivano anche grazie a enti di carità come l’opera San Vincenzo. Quei ragazzi, figli di donne che con coraggio scelsero di essere trattenute in seminario, restarono nascosti obbedendo alle madri. Quelle donne dai primi di dicembre furono testimoni di un altro drammatico episodio. Dal piano di sopra, che fino al giorno prima era restato piuttosto silenzioso, iniziò a giungere il calpestio e il vociare di una moltitudine di persone. Erano gli ebrei di Asti, arrestati in conseguenza del famigerato “Ordine di polizia n. 5” di Guido Buffarino Guidi, ministro degli interni della Repubblica Sociale. Un episodio ignobile, nella grande vergogna della Shoah, fu quello di cui fu artefice il capo della Provincia di Asti, Renato Celio, che assicurò agli ebrei la sua protezione dietro il pagamento di un’ingente somma in denaro e oro. Nonostante il versamento, oltre 50 persone furono catturate e deportate ad Auschwitz. Della comunità ebraica si salvarono solo l’insegnante Enrica Jona e i coniugi stranieri Teodoro e Liselotte Rozaj. Un pezzo di storia del Ventesimo Secolo era passata sopra le teste delle madri prigioniere, che il 24 dicembre si trovavano ancora bloccate nel seminario. Ma proprio quel mattino giunse una visita che diede la svolta all’intera vicenda. A bussare alla porta di piazza Catena arrivò Umberto Rossi, vescovo di Asti dal 1932. La mattina della vigilia si presentò alle guardie della milizia, che possiamo immaginare imbarazzate davanti a quella inaspettata visita, portando con sé solo una valigetta. Fatto entrare nelle stanze dove ancora erano tenute prigioniere 68 donne astigiane, si rivolse a queste ultime con una frase che suonava più o meno così: «Care mamme, consideratemi prigioniero insieme a voi, passerò qui la notte di Natale. Pregheremo insieme. Abbiate la cortesia di sopportarmi, mi metterò in un angolo».

Nella valigia portava vestaglia e pigiama, ma al monsignore non fu necessario vestirsi per la notte. In città aveva iniziato a diffondersi la notizia del vescovo che si era fatto imprigionare volontariamente, per restare insieme a quelle madri che avevano imposto ai figli di non presentarsi alla chiamata dell’esercito. Così, nel pomeriggio del 24 dicembre 1943, parecchi astigiani, informati e stimolati dai parroci, avevano iniziato a radunarsi in piazza Catena, davanti a quella porta. Gli assembramenti pubblici erano proibiti, in quegli anni simili iniziative erano stroncate senza indugio. Ma in quella vigilia di Natale le cose andarono diversamente. La folla silenziosa, composta anche da tanti parenti delle donne rinchiuse là dentro, restò lì fino a sera. Fino a quando le autorità decisero di mollare la presa: era già buio quando le donne uscirono finalmente dal seminario, riabbracciando i propri cari. Tranne i figli, ovviamente, che per la maggior parte sarebbero rimasti nascosti ancora a lungo, per evitare di essere inquadrati tra le fila dell’esercito repubblichino. Nelle stesse ore vennero liberati anche gli uomini trattenuti al casermone. Ma perché i fascisti cedettero? Tutto merito del gesto del vescovo Umberto Rossi, o c’era dell’altro? Certamente il monsignore giocò un ruolo importante in quella vicenda e le autorità non avevano interesse a scontrarsi con le gerarchie ecclesiastiche. Ma è altrettanto vero che il tentativo di imprigionare padri e madri di ragazzi nemmeno ventenni venne progressivamente abbandonato perché considerato poco utile “se non controproducente” ai fini del consenso popolare. Successe in quasi tutta l’Italia del Nord: casi simili a quello di Asti sono documentati in città vicine come Cuneo e Alba. Ma c’è dell’altro, l’arruolamento nell’esercito della Rsi continuava a essere deludente. C’è un rapporto del capo della Provincia al Ministero dell’Interno che trasmette la situazione non rosea nell’Astigiano: si parla di uno «spirito pubblico fiaccato e poco incline al sacrificio». Ma la difficoltà ad arruolare soldati caratterizza l’intera storia della Repubblica Sociale. Alla fine del gennaio 1944 i capi delle province, Asti compresa, inviarono una circolare ai comuni in cui si chiedeva il censimento di tutti i cittadini che erano sotto le armi alla data dell’8 settembre. Che fine avevano fatto? chiedeva la circolare. Erano irreperibili, erano tornati a casa, o forse prigionieri degli alleati? Alla fine di febbraio avevano risposto solo 12 comuni, segno questo di uno sfaldamento della Rsi che non riusciva a mantenere sotto controllo le sue stesse istituzioni. La richiesta della Provincia venne reiterata e a maggio furono sollecitati i 90 comuni ritardatari. La campagna di arruolamento di Salò fu caratterizzata poi da strategie contraddittorie: «A giugno del 1944 apparvero i manifesti, firmate dall’allora sottosegretario Giorgio Almirante, che minacciavano la fucilazione per chi non si fosse presentato», ricorda ancora Giovanni Bosia. Ma a ottobre le autorità fecero un passo indietro, stabilendo l’amnistia. Niente fucilazione, insomma. Anche perché ormai erano in tanti, anche tra i ragazzi arruolati nell’esercito regolare, ad aver scelto la strada della Resistenza. La guerra sarebbe finita il 25 aprile 1945.
La Scheda