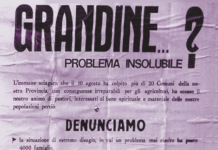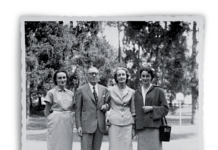Il calendario dice che arriva la primavera. Quando ero ragazzo le stagioni si toccavano, si annusavano, si sentivano sulla pelle. Soprattutto questa, attesa più delle altre perché liberava l’anima dal tetro grigiore dell’inverno, sospirata e immaginata a ogni schiarita, a ogni riflesso di pallido sole in una pozzanghera.
Già dopo le vacanze di Natale, quando andando a scuola vedevo i candlè (le stalattiti) di ghiaccio pendere dalle canàl (le grondaie), mi consolavo pensando che a l’Epifania eldì sa slunga del pas di na furmìa, San Bastian el pas d’in can, Sant’Antoni n’ura bon-a. Una filastrocca che insegnava date legate ai santi del calendario: l’Epifania il giorno si allunga del passo di una formica, a San Sebastiano (20 gennaio) del passo di un cane, e a Sant’Antonio (17 gennaio) già si recupera un’ora complessiva di luce rispetto al solstizio d’inverno del 21 dicembre.
E a Carnevale, anche se il ciglio della strada era bianco di brina, mi rincuoravo dicendomi che fervè el scauda i vè, febbraio riscalda anche le zone in ombra, mentre quelle esposte al sole sono i surì. Ma subito temevo improvvise disillusioni ricordando che el lù ha mai mangià l’invern, il lupo non ha mai mangiato l’inverno: il bel tempo troppo anticipato è ingannevole, perché ogni stagione fa il suo corso, inesorabilmente. Almeno così capitava allora.
Ma se il lupo non mangiava l’inverno, in compenso i primi tepori gli regalavano il pandulù: nei punti più riparati, soprattutto sotto i densi tappeti di foglie del bosco, la neve coccolava e nutriva, sciogliendosi goccia a goccia, le primule selvatiche, il pane del lupo, di un giallo sbiadito come la polenta fatta con il mais otto file. A proposito della primavera, mi torna spesso alla mente una storiella che raccontavano i nonni ai nipoti.
Un poveraccio, che aveva quattro filari, un campetto e un pezzo di prato, campava (male) facendo il laurau, il bracciante a giornata: un giorno qui, l’altro là, a zappare o a spaccare legna per una paga misera. Finita la torchiatura di quelle poche uve, messo al sicuro il granoturco, andava a chiedere lavoro in giro. All’inizio dell’inverno, mentre offriva i suoi servigi a un grosso proprietario terriero, questi lo interruppe e disse, indicando i fiocchi di neve che cadevano:«Vugti, cuj lì son tücc laurau», vedi, quelli sono tutti garzoni, alludendo al fatto che la neve proteggeva il grano («sotto la neve pane», si diceva), nutriva le viti, assicurava abbondanza d’acqua nei pozzi e manteneva morbido il terreno.
Allo sbocciare della primavera il ricco possidente, che aveva bisogno di collaboratori, andò a casa del bracciante per ingaggiarlo e lo trovò sdraiato sul prato. Gli fece la proposta e lui rispose, indicando i fiori sbocciati da poco intorno a lui:«Vugti, cuj lì son tücc padròn», vedi, quelli sono tutti i miei padroni, perché preferiva restarsene tranquillo a godersi la bella stagione.