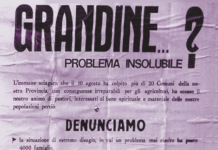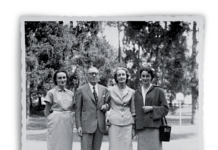Chi fosse entrato, una delle due sere di Pesach (la Pasqua ebraica, che cade tra il 14 e il 22 di Nisàn, fra marzo e aprile del calendario gregoriano) in una delle case delle Comunità israelitica astigiana dei primi anni del Novecento, avrebbe trovato la tavola imbandita con una tovaglia di raso bianco intessuto di fili d’argento, riservata proprio al Seder, la cena pasquale cui partecipano anche ospiti invitati. Allora – e precisamente nel 1902, come attesta l’Annuario di Asti – la popolazione ebraica ammontava a 360 persone e continuava a praticare il suo rituale, originario della Francia settentrionale, detto Appàm, dalle iniziali ebraiche delle tre località in cui era giunto attraverso ignote vicissitudini migratorie per restare inalterato nel tempo: Asti, appunto, Fossano e Moncalvo.
Non era il massimo storico della popolazione, registrato subito dopo l’Unità (450 persone nel 1866) ma neppure il minimo: quei 10 membri del 1984 che comportarono il declassamento della comunità a sezione dipendente da Torino. Ma già prima, nel ’31, con la legge Falco sulle Comunità israelitiche, Asti aveva perso la sua autonomia e, con una sessantina di membri, era stata aggregata ad Alessandria.
Dal 1723, anno in cui lo stato sabaudo aveva istituito i ghetti obbligatori, la Comunità astigiana risiedeva nella zona compresa fra la contrada degli Israeliti (dal 1873 via Aliberti, che mantiene ancora oggi la caratteristica piccolo-commerciale originata dalla presenza ebraica) e il vicolo San Bernardino (dal 1895 via Ottolenghi), dove già da tempo sorgeva la Sinagoga che sarà ristrutturata e ampliata negli anni Ottanta dell’Ottocento grazie all’intervento dei banchieri Ottolenghi. In mezzo, prima il clima di libertà e di emancipazione avviato nel periodo napoleonico e la definitiva abolizione dei ghetti con lo Statuto Albertino del 1848 (è il periodo di cui racconta Guido Artom ne I giorni del mondo), poi l’esodo di molte famiglie verso le grandi città del Nord alla ricerca di lavoro e affermazione professionale, infine l’antisemitismo e la caccia all’ebreo, anche ad Asti: una trentina di persone furono deportate e solo tre ritornarono.

Ma prima della guerra nazifascista, pur con l’ammorbidirsi del rigore di alcune peculiarità liturgiche, nelle case astigiane si continuava a celebrare la fine del lungo digiuno dello Yom Kippur (il Giorno dell’espiazione, che nel calendario ebraico comincia al crepuscolo del decimo giorno del mese di Tishrì che cade tra settembre e ottobre, e dura 25-26 ore) con la bruscadèla, una fetta di pane biscottato imbevuta di vin brûlé speziato, consumata prima della cena, nel menu della quale non bisognava mescolare carne e latte.
Nei giorni precedenti la Pasqua, invece, si andava alla “ricerca del lievito”, che i bambini vivevano come una specie di caccia al tesoro di tutto ciò che è lievitato, che deve essere bruciato in quanto simbolo degli istinti meno puri.
«I nostri genitori – raccontano gli allora ragazzi Debenedetti, Maria e Paolo – nascondevano pezzi di cibo lievitato per rendere più vivace la ricerca, mentre il nonno prenotava dal forno di Ricci, in corso Alfieri, le azzime che, sovrapposte, dovevano troneggiare sulla tovaglia del Seder». Accanto, le uova sode, anzi sodissime, a volte bollite per più di mezzora, il sedano, la lattuga, le erbe amare, lo zampetto di agnello e, autentica golosità anche se non priva anch’essa di valore simbolico, la Haroset, una sorta di composta di frutta fresca e secca: mela grattugiata, polpa di banana, noci, nocciole, miele, succo d’arancia, vino kosher. Questa la ricetta di casa Debenedetti, ma la formula è abbastanza libera e può contemplare anche datteri, amaretti e un pizzico di polvere di mattone, a rafforzare il significato della Haroset, quello della malta impastata dagli Ebrei durante la schiavitù in Egitto.
Le quattro coppe rituali, che intervallano i vari momenti del Seder, si colmavano del vino kosher prodotto da Piero Norzi di Moncalvo. Nel complesso rituale di questa cena di primavera, vissuta come passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, trova posto un canto eseguito prima dei salmi alleluiatici, il Dayenu (letteralmente: “questo ci sarebbe bastato”), un ritornello che insegna a contentarsi di ciò che ci è stato donato, cogliendo il buono in ogni momento.
E i bambini cantavano la filastrocca della “Fiera dell’Est”
Mentre i bambini e i ragazzi aspettano con ansia di intonare la filastrocca della Fiera dell’est e del capretto che per due zuzim (soldi) mio padre comprò (la canzone di Angelo Branduardi è una rielaborazione proprio di questo canto), e si apre la porta per far entrare il profeta Elia, in qualche famiglia astigiana – la fonte storica sono state le sorelle Jona – si porta in tavola la zuppa del Dayenu, preparata ammollando delle azzime in un brodo di pollo, tacchino e porro; lo si addensa con le carni dei volatili dissanguate, lessate e sminuzzate e, infine, vi si rompe sopra un uovo crudo.
Ancora valori simbolici, certo, ma per una ricetta godibilissima che rivela affinità con la zuppa della regina, una minestra raffinata e antica, che affonda le radici nelle cucine rinascimentali.