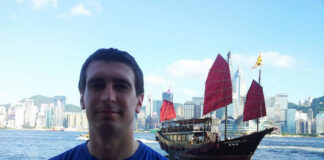La “mia Africa” da bambino sulle ginocchia del Negus
Nel soggiorno di Aris d’Anelli le foto affollano mobili e ripiani. Tutte raccontano di una vita intensa, di una famiglia allietata da molti nipoti. Non lontano dal traguardo dei novant’anni, è stato uno dei medici che più hanno contribuito alla crescita dell’ospedale di Asti. È anche uno degli scrittori astigiani più prolifici. Ha raccontato passioni e storie che lo riguardano. A cominciare dal romanzo L’uomo che parlava con i fili, storia di un telegrafista italiano nell’Africa coloniale.
Una biografia di suo padre?
Quasi. In effetti ripercorre la storia di mio padre, con il finale romanzato.
Lui era il primo di tanti fratelli, aveva trovato lavoro come impiegato statale alle poste
e telegrafi. Uomo molto intraprendente, aveva chiesto di andare in Eritrea.
E fu accontentato: prima fu mandato a Macallé, nello stato etiopico, dove si dedicò alla riparazione dell’esistente linea telegrafica. Quindi raggiunse Addis Abeba, dove italiani ed etiopi lo nominarono direttore delle poste e telegrafi.
La sua famiglia era in buoni rapporti con la corte?
Sì, ho persino una foto di me bambino insieme al negus Hailé Selassié. I contrasti furono piuttosto con gli italiani, che vollero sapere da mio padre i dettagli di un accordo tra l’Etiopia e il Belgio relativo ad armi e addestramento. Ma lui non rivelò nulla di quanto si era detto nell’ufficio del Negus, così lo rimossero dalla direzione e lo trasferirono in Eritrea, in un piccolo ufficio telegrafico.
Che ricordo ha di quel periodo in Africa?
Lì ho frequentato le scuole elementari, i miei compagni erano quasi tutti africani. Ricordo che avevamo come maestro un padre cappuccino, una persona alla buona che scriveva “quore”, con la “Q”. I miei per divertirsi andavano a cavallo o giocavano a tennis, in fondo i bianchi erano i privilegiati: sia chiaro, tra loro poteva esserci anche gentaglia, ma in genere erano considerati un’élite. Avevamo qualche amico etiope, ricordo l’abissino Afe Work, un dignitario di origini nobili che aveva sposato una donna italiana e aveva tre figli. Fu un’amicizia particolare, continuata nel tempo. So che poi cadde in disgrazia, ma continuò a insegnare italiano all’università.

Poi, nel 1935, lo scoppio della guerra tra Italia ed Eritrea.
Fu allora che ci trasferimmo a Torino. E quando Asti divenne provincia, i miei genitori vennero qui. Furono anni molto duri, per due volte avevamo perso tutto. Quando partimmo da Addis Abeba e quando lasciammo l’Eritrea non avevamo che due valigie con noi. Ad Asti le cose cominciarono ad andare meglio, mio padre aveva esperienza e divenne direttore del telegrafo. Tra l’altro, anche il padre di mia moglie venne qui per lavorare all’indomani della nascita della provincia. Una bella coincidenza, altrimenti non ci saremmo mai incontrati.
Quando prese la decisione di diventare medico?
In realtà, ai tempi del liceo classico mi passavano per la testa idee ben diverse dalla medicina. Avevo tra i docenti il professor Pietro Cazzani, un uomo di cultura universitaria. A quell’epoca scrivevo brevi recensioni cinematografiche per La Provincia (che in seguito sarà ribattezzata La Nuova Provincia, ndr), ma c’era chi non prese bene il fatto che avessi quello spazio, perché ero considerato troppo giovane. Comunque già allora avevo una forte passione per il cinema, e forse se non ci fosse stata la guerra avrei tentato di entrare al centro sperimentale di cinematografia.
Allora fu la guerra a farle scegliere medicina?
Quando scoppiò la guerra, ricordo che mia madre pianse. L’autarchia fu un disastro, tutto era precario. Date le condizioni storiche, scegliere la concretezza della medicina fu una strada quasi obbligata.
Ma posso dire di non essermi mai pentito della scelta.

Rimase coinvolto nel conflitto?
Nel 1943 fui chiamato alle armi dalla Repubblica Sociale. Non ci andai, e mia madre venne praticamente presa in ostaggio in seminario. Dopo qualche giorno mi presentai, fortuna volle che fossi già iscritto a medicina. Mi misero aiutante di sanità della Croce Rossa, anche se non sapevo praticamente nulla di medicina, e arrivai alla Liberazione senza aver indossato alcuna divisa. Ho praticamente rimosso i ricordi della guerra, oggi mi rimane solo la memoria della sua inutilità, della sua violenza.
Con il dopoguerra venne anche un periodo più spensierato?
Non ho potuto perdere troppo tempo. Anzi, come tanti altri giovani di allora, non ci concedemmo molti svaghi, credo che gli italiani volessero soltanto andare avanti. Così mi laureai nel 1949, anche se nel frattempo avevo seguito Cazzani e altri per dare vita all’associazione culturale “La giostra”. Grazie a Eugenio Guglielminetti fu un momento di fervore per la cultura astigiana, vennero in città grandi della pittura come Casorati. Ci fu una mostra, si vendevano suoi lavori a 150 lire, col senno di poi sarebbe stato un ottimo investimento. Fondammo anche uno dei primi cineclub italiani, ricordo la proiezione di Femmine folli e de Il cane andaluso. Ma quel fermento scemò già negli anni Cinquanta.
Finalmente, varcò la soglia dell’ospedale con un camice addosso.
Esordii come medico di guardia. Non si guadagnava niente, si prendevano gettoni di presenza per le notti passate in ospedale. Ma questo mi consentì di specializzarmi in cardiologia a Torino, poi vinsi il concorso per assistente di medicina e nel 1966 divenni primario del mio reparto. E da allora ho sempre lavorato in cardiologia, che in origine si occupava solo di elettrocardiogrammi, visite ed esami. Insomma, eravamo al servizio degli altri reparti per tutto ciò che aveva a che fare con il cuore, in particolare collaboravamo con la pediatria di Currado. Finalmente divenne un reparto, con degenze e assistenza continua ai malati. A metà degli anni Settanta nacque l’unità coronarica, una delle prime in Piemonte, e c’erano regioni che non ne avevano.

Fu una creatura sua, in un certo senso.
Sì, un pochino sento come se lo fosse. Era nata nonostante qualche ostacolo, i medici si vedevano portare via una parte di lavoro. Il cuore non lo cura solo il cardiologo, ovviamente. Ho insistito perché fosse concepita con criteri di assoluta modernità, doveva essere qualcosa che rompesse la routine. Mi impegnai in lunghi stage al Niguarda di Milano, con il professor Rovelli, uno dei più eminenti cardiologi in Italia. Imparai cose che qui non avrei mai potuto fare, ci passavo le notti, dal venerdì sera al lunedì mattina. Ne è valsa la pena, ad Asti ho trasmesso quello che avevo imparato ai medici Caratti, Zola e molti altri dopo di loro. Arrivammo a 16 tra aiuti e assistenti, l’attività si era enormemente ingrandita, si facevano anche ricerca e insegnamento. C’era persino chi ci visitava, anche dall’estero. Ho lasciato il reparto nel 1990, un anno dopo sono stato sostituito dal dottor Gaita.
Prima della pensione, però, lei tornò in Africa. Per due volte.
Nel 1978 andai a Goma, in Zaire, per un gemellaggio. Ero con un sacerdote astigiano, don Mignatta, altri medici e le nostre famiglie. Colsi l’occasione per vedere le condizioni sanitarie del paese: erano disastrose. La zona era stata colpita da un’eruzione che aveva coperto campi fertili. Demmo dei suggerimenti per migliorare le cose, ma non servì a molto. Penso che anche oggi sia cambiato poco, forse non è ancora giunto il momento della riscossa per gli africani.
Ma lei rivide anche i luoghi della sua infanzia.
Sì, era l’anno della grande carestia in Etiopia, il 1986. Ad Addis Abeba mi mandarono in un lebbrosario, ci andai con mia moglie. Lei lavorò benissimo facendo assistenza, nonostante non fosse né medico né infermiera. Fasciava i malati, in fondo la possibilità di contagio è bassa. Quel posto era un vero e proprio villaggio di lebbrosi, si sposavano addirittura tra loro. Il problema principale erano le malattie da fame, la lebbra veniva curata da un frate francese, che di tanto in tanto passava di lì. E poi c’era il problema degli aiuti umanitari, che non avevano alcun criterio: ad esempio arrivavano casse e casse di antidiabetici, che a un popolo che muore di fare non servono certo.

Ritrovò qualcuno che aveva conosciuto da bambino?
Non in quella occasione. Conobbi poi in Italia una principessa etiope, figlia di un capo che aveva combattuto contro l’Italia. La ragazza era stata presa prigioniera, portata da noi e fatta studiare dalle suore. Aveva sposato un romano, mi disse che da bambini ci eravamo conosciuti alla corte del Negus, io onestamente non ne ho memoria. In Africa ho lasciato il cuore, quando tornai ad Addis Abeba per la carestia sentii che era doveroso aiutare quelle persone, che era un modo per restituire quanto di buono mi avevano dato.
Quando fu che trovò il tempo per scrivere i suoi libri?
Da quando sono andato in pensione ho avuto più tempo per tutto, dai viaggi alla scrittura. Iniziai con L’uomo che parlava con i fili, allora avevo come tutor Paolo Debenedetti, che mi suggeriva sempre di tagliare, tagliare, tagliare. Ho sempre avuto una certa tendenza a leggere, e a scrivere. Anche quando facevo foto, volevo raccontare qualcosa. Da ragazzo mi divertivo a scrivere temi, più tardi a Natale con gli amici raccontavo favole. Qualche soddisfazione l’ho avuta anche dalle pubblicazioni scientifiche, ne ho scritte un centinaio. Qualcuna ha avuto anche discreta fortuna.
In reparto è stato maestro dei suoi allievi medici, ma una volta in pensione non ha smesso gli abiti dell’insegnante.
Per quindici anni ho insegnato Storia del cinema all’Università della terza età. Devo ammettere che mi divertivo moltissimo, ogni anno avevamo un tema diverso: cinema inglese, francese, il Neorealismo. Mi preparavo le mie lezioni, si discuteva, ogni proiezione era seguita da un centinaio di allievi.

Da liceale scelse di iscriversi a medicina piuttosto che a cinematografia. Che cosa suggerirebbe ai ragazzi di oggi, di essere realisti o di seguire lo spirito?
A volte si sceglie una strada obbligata a cui poi ci si affeziona. Se a 17 anni non avessi seguito la strada della medicina, non avrei ottenuto tutto quello che ho ottenuto. Per me la medicina è stata la cosa più grande. Se dovessi riassumere il tutto in un aforisma, direi: vai dove ti porta il cuore, ma ragiona. Ho un nipote che si è laureato in ingegneria, ora lo vedo affrontare il lavoro con grande entusiasmo, anche se si sta scontrando con le prime delusioni. Bisogna mettere davanti a tutto il lavoro e la serietà, ma ai ragazzi dico: trovatevi sempre un’ideale, un luogo dove rifugiarvi quando ne avete bisogno.
La letteratura, ad esempio, la fotografia, la musica. Sono tutte cose che ti possono risarcire di tante durezze che si incontrano nella vita, nel lavoro, nella sorte.
D’altra parte noi cerchiamo di fare le cose al meglio, ma non sempre vanno come vogliamo. Io nella vita ho avuto fortuna, sono ancora qui a raccontare, riesco a ricordare, al contrario di tanti amici e colleghi che purtroppo dalla vita hanno avuto batoste.
Le Schede