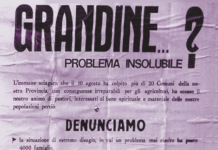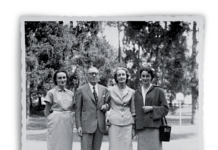Finalmente seduti, a tavola. Anzi, ai tavoli rotondi con le tovaglie drappeggiate fino a terra. Dopo aver assistito alle coreografie scherzose allestite dagli amici degli sposi e agli infiniti scatti dei fotografi, destinati al book che si sarà poi costretti a vedere.
Dopo aver percorso un tot di chilometri per raggiungere la possibilmente prestigiosa location, dopo essersi aggirati intorno alle varie postazioni predisposte dal catering per pescare finger food freddi e caldi: gamberetti in salsa rosa, paté di trota, salmone marinato al riso nero, spiedini di pollo al lime, tronchetti di crêpes, olive ripiene, pizzette esotiche… Tenendo in precario equilibrio calici di aperitivo, bicchierini e barchette con relative forchettine, senza dimenticare uno sgargiante tovagliolo di carta, in tono con le decorazioni floreali. Non che tutte le giovani coppie scelgano queste formule per festeggiare il loro matrimonio. C’è chi fa ancora di più, ingaggiando un wedding planners che inventerà di tutto: dalle fantasiose bomboniere ai droni per filmare dall’alto corteo, lancio di petali di fiori, frizzi e lazzi, servizio fotografico e quant’altro. Come si spiegherebbe altrimenti il successo riscosso dai numerosi reality, d’importazione e nostrani, dedicati al “giorno del sì”, affinché esso sia “indimenticabile” e “da favola”? Ma ci sono anche famiglie che, in congiunture ristrette come quelle odierne, tendono ad adottare condotte di consumo più misurate, riducendo il budget per le spese di contorno.
Altre – e la tendenza si sta diffondendo – coniugano la categoria “risparmio” con quella di “solidarietà” ed entrano nel circuito della beneficenza, devolvendo ad associazioni che operano nel sociale parte del budget e dei regali in denaro fatti dagli invitati.

Un altro mondo, davvero, erano i banchetti rurali di nozze tra fine Ottocento e la prima metà del secolo scorso. Per lo meno quelli in epoche di pace. Così si legge nell’Inchiesta Agraria Jacini del 1880: «In due sole circostanze [le famiglie contadine, ndr] si abbandonano alle intemperanze del cibo e delle bevande, cioè nell’occasione della festa patronale del paese e in quella delle nozze. Allora mangiano per quattro, ed alzano il gomito con un po’ troppa frequenza, di guisachè è facile in simili occasioni trovarli brilli. Sfuggite tali occasioni, e ad eccezione di inviti da qualche parente o amico, conservano una sobrietà spartana». Altro che «sobrietà spartana», si tirava la cinghia e si mangiava per sopravvivere. Restavano giusto quelle due o tre ricorrenze straordinarie l’anno in cui si dava sfogo all’opulenza e alla trasgressività. In quelle occasioni si cercava di “non badare a spese”, riuscendo magari a contenerle con il ricorso ai prodotti della cascina: sottoli e sottaceti casalinghi, salami cotti e crudi stagionati in cantina, polli ruspanti da arrostire, ortaggi “fini” dell’orto, come piselli o spinaci, farina per fare la pasta (fossero “biavette” per il brodo o tajarin da condire con un comodato di carni e salsiccia). Raramente compariva il formaggio: quello autoprodotto era ritenuto troppo “quotidiano” o grossolano, quello acquistato una spesa inutile.
Per dessert, dolci casalinghi accompagnati dalla frutta sciroppata “messa via”. Talora si faceva confezionare dal pasticciere una torta speciale con la crema e le guarnizioni floreali di pasta d’ostia. Il dolce nuziale, del resto, ha origini antiche e un forte significato simbolico: da quello di sesamo e miele, accompagnato a datteri e mele cotogne, di memoria classica, alle torte “alte” medioevali, ottenute assemblando pani e biscotti donati dai convitati, fino alle torte glassate (lo zucchero bianco fine costava caro) e, più avanti, a ripiani, come testimoniano immagini degli anni Cinquanta.

Per quanto riguarda il luogo, per lo più i banchetti erano autogestiti. Se le donne di casa non ce la facevano a governare numeri e portate, si ricorreva alle Cusinere, cuoche specializzate in pranzi d’occasione. Figure interessanti, quelle delle Cusinere, utili anche a comprendere come certi piatti festivi di ispirazione alto-borghese siano entrati nel mondo familiare contadino, prima che nei ristoranti tipici.
Si trattava di giovani paesane che erano state “a servizio” presso ricche famiglie cittadine, dove avevano appreso ricette, tecniche di cottura, utilizzo di certe stoviglie (dalla bibinera per cuocere il tacchino a particolari stampi per dolci, assenti nella frugale cucina contadina).
Si spiega così, secondo gli studiosi, l’ingresso di piatti complessi che hanno finito per diventare cardini del mangiare “alla piemontese”: il vitel toné, l’insalata à la russe, la fonduta, la finanziera, la selvaggina in salmì, il bonet. Fino al fritto misto e al servizio dei bolliti con le loro salse. «Alcune specialità della Cusinera –scrive Gianluigi Bera in Codice della cucina autentica di Asti – rimarranno nell’empireo inarrivabile del paradiso gastronomico rurale; altre saranno adottate diffusamente o addiritura universalmente».