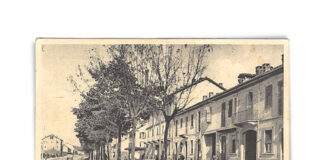Mi sembra di vederla quella luce accesa in fondo al corridoio. Mentre la città dormiva mamma lavorava e, punto dopo punto, faceva nascere i suoi vestiti. ll ronzio della macchina da cucire si mescolava al rumore delle rare auto di corso Casale, e quando calava il silenzio si sentivano le forbici che, tagliando il tessuto, scivolavano sul tavolo con un suono singolare. A quei tempi non avevo ancora la mia cameretta, ma dormivo sul divano letto della cucina del nostro alloggio di corso Casale 88. La stanza in cui mamma lavorava era la più grande dell’appartamento, e per me era un po’ come il centro del mondo. Di giorno si animava di parole e di persone, con la Rosita che la aiutava e le clienti che venivano a misurare i capi, spesso accompagnate da amiche e conoscenti; all’occorrenza un grande tendone posto in diagonale divideva la stanza in due, affinché si potesse creare un po’ di intimità per le prove. Io, figlio unico di papà Piero e mamma Teresa, passavo gran parte del mio tempo lì, a giocare con i soldatini in mezzo ai tessuti, e spesso mi trovavo a fantasticare, pensando a quello che succedeva al di là di quel tendone.

Un’infanzia tra stoffe, bottoni e passamanerie
Eravamo alla fine degli Anni ’60 e fare la sarta era un mestiere di un certo prestigio. La città aveva molti negozi di tessuti: Novatessile, Bonello e Grillone, che ancora oggi sono parte della tradizione astigiana, ma anche Tessuti Pio in piazza San Secondo e Marisa in via Fontana, che ora non ci sono più. Per me era davvero una festa quando mamma mi caricava sulla sua bici e mi portava con lei in centro, “a comprare le forniture”. Si andava in piazza Statuto nella storica sede Foderami dei signori Marchisio, e poi in un minuscolo negozio di bottoni in piazza San Secondo, credo il più piccolo negozio del mondo, con la mitica signora Noemi e la figlia Dea. Ed era incredibile come quei pochi metri quadri potessero contenere una tale quantità di bottoni, nastri e passamanerie.
C’era (e c’è tuttora) anche Brumana sotto i Portici dei Cestai, ma lì si andava di meno. Ogni sarta aveva le sue preferenze, e sotto sotto si respirava anche un po’ di sana rivalità. Mamma si distingueva per aver imparato da una “sarta da uomo” – dalla Irma – e di questo era orgogliosissima. Lì aveva imparato l’arte del capo spalla, e in effetti era da tutti riconosciuta per saper far bene le giacche. Ricordo che quando le si chiedeva perché avesse deciso di imparare a cucire, rispondeva con convinzione che l’aveva fatto “per non andare a lavorare in campagna”, ma credo ci fosse dell’altro – una sorta di tassello creativo nel Dna della famiglia – visto che anche la sorella aveva intrapreso la stessa strada.
La loro famiglia, i Brunetti, era originaria di Caniglie, ma le due sorelle una volta sposate erano venute in città e come sarte erano conosciute con i cognomi dei mariti: Baracco e Bertonasso.

La zia Malvina si era specializzata in vestitini per bambine
Perché anche zia Malvina, di due anni più grande di lei, era una sarta bravissima. Si era specializzata negli abiti per le bambine e le sue creazioni erano di una delicatezza infinita, poco più grandi di vestiti per bambole, curati minuziosamente nel dettaglio con piccoli ricami, filze e bottoncini. Aveva una clientela di prestigio e ricordo quanto fosse lusingata nel poter dire che serviva le gemelline dei Riccadonna di Canelli e la prole di certa crème astigiana.
Mamma e zia erano legatissime, siamesi nell’anima. Sempre insieme. Se Malvina era particolarmente mite, al contrario Teresa era intraprendente e sicura di sé. A metà degli Anni ’70 la stanza con il tendone si era evoluta in un piccolo atelier: c’erano il laboratorio, la stanza per le misure, la sala d’aspetto e un vivace via vai di persone. Lei tagliava, faceva i cartamodelli, cuciva, consigliava linee, colori e tessuti. Aveva due dipendenti alle quali insegnava il mestiere – prima Ada e poi la Rosalda che non ha mai smesso di cucire – e si faceva aiutare dalle signore del quartiere, come l’eroica Luigina che, con il suo affetto e la sua energia, le fu amica per tutta la vita e riuscì anche a sollevarla da una brutta depressione.

Il cappotto nuovo dei Santi e gli abiti da ballo per i veglioni
Ogni stagione aveva i suoi riti.
A novembre, alla ricorrenza dei Santi, per molte clienti era obbligatorio indossare un cappotto nuovo; seguivano i vestiti di Capodanno e quelli per i famosi veglioni a tema che si tenevano al Salera, per poi arrivare alla primavera dove iniziava il lungo, lunghissimo periodo dei suoi adorati abiti da sposa. Credo che ne abbia confezionati almeno un centinaio, e posso dire che ogni abito era come un parto. Dopo una lunga gestazione, di prove e controprove, il copione prevedeva che venissero rifiniti nella notte e portati al mattino del matrimonio, celati da teli, perché nessuno doveva vederli. Spesso c’era anche da confezionare l’abito per la mamma della sposa. Li ricordo semplicemente perfetti, tanto che oggi nel pensarci mi sembra così riduttivo chiamarli solo “abiti”. Erano pezzi unici come opere d’arte.
Poi arrivarono gli Anni ’80, e i momenti più attesi dell’anno erano quando la Camera di Commercio organizzava la Mostra dell’Artigianato: un bell’evento per la città, a cui erano collegate le sfilate, prima nel Cantinone di Piazza Alfieri, poi al Politeama e anche al Teatro Alfieri di Torino.

Per questi eventi si era davvero tutti molti concentrati; io, crescendo, aiutavo, un po’ osservavo, e giorno dopo giorno, poco per volta, senza saperlo imparavo, ignaro di quel destino che mi avrebbe portato a continuare in qualche modo il lavoro di mia madre. Era il 1988 quando mi arrivò una richiesta di colloquio dalla Miroglio di Alba, allora conosciuta come Vestebene. Mi ero appena laureato, ed ero convinto che nella vita mi sarei occupato di arte e di capitelli romanici, ma con persuasione mia madre mi fece capire che a quel colloquio ci dovevo proprio andare: perché ero cresciuto in mezzo alle stoffe, perché avrei fatto bella figura e perché “nella vita non si sa mai”. Aveva ragione.
Dopo poco più di un mese, io, il figlio della sarta di corso Casale, venivo assunto da quella che era (ed è tuttora) una delle più grandi aziende italiane di abbigliamento. D’altra parte nessuno poteva negare che avevo alle spalle un lungo corso di formazione, e con un’eccellente insegnante!
Mi avrebbe atteso un cammino impegnativo e affascinante, una strada che avrei percorso con passione e tenacia, ma anche con una certa discrezione, “perché – diceva mamma – non bisogna mai montarsi la testa”.
Una strada che, passo dopo passo, mi ha portato alla Direzione creativa di un brand prestigioso e a un riconoscimento importante che mai mi sarei aspettato dalla vita: la Stella al Merito per il Lavoro, ricevuta il primo maggio di quest’anno.
Un premio che non è soltanto mio, ma anche di quella donna così speciale – madre, artigiana, artista – che mi ha permesso di scoprire e di amare così tanto questo mestiere.
Quell’ultimo speciale abito da sposa

Adesso “la Baracco”, così come la chiamavano le sue clienti, non c’è più. Mamma se ne è andata due anni fa, a 83 anni, rapita dall’Alzheimer. Fino a quando ha potuto ha cucito, e in un certo modo ha continuato a farlo, anche quando non le era più possibile. Ricordo il giorno in cui mi disse che non riusciva più a finire un vestito da sposa, e poi mi accompagnò nella stanza in fondo al corridoio per farmi vedere quello che per lei era un abito: in realtà un semplice lenzuolo bianco appoggiato su un manichino, che con cura doveva aver piegato e drappeggiato tutto il giorno. Ci fermammo a guardarlo. Lei scrollava leggermente la testa, e io ero lì senza sapere che cosa dire. Poi decisi che anche per me quel lenzuolo doveva essere un abito da sposa. E mi sembrava davvero di vederlo, sapete? Era bellissimo. Un abito meraviglioso. Sì, forse il più bello di tutti: il suo capolavoro.