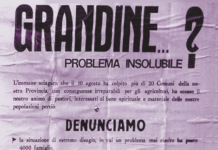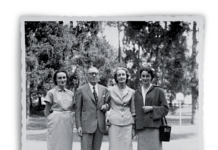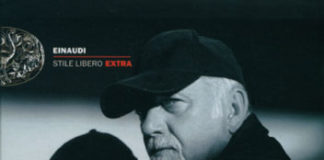Un potente monastero nel cuore della città dal medioevo al XIX secolo

permuta di terre pubbliche, che vede protagonisti il chierico Augustinus, rappresentante dell’abbazia di Sant’Anastasio, e il gastaldo regio Sonderulf.
Non si conosce la proprietà delle terre, se fossero appartenute al fisco longobardo o se provenissero da confische seguite alla conquista franca, così come sono ignote le origini del monastero di monache benedettine annesso alla chiesa, di cui si hanno notizie certe dai primi anni dell’XI secolo.
“Sub imperio abbatisse”, e quindi di pertinenza del monastero, risultano già all’inizio dell’XI secolo molte proprietà e beni, testimonianza di antiche elargizioni, tra cui i monasteri femminili di Santa Maria di Narzole, tra i fiumi Tanaro e Stura, della Santa Trinità, presso
il torrente Veglia, di Santo Stefano “de Lacu”, vicino all’attuale Beinette, e di Sant’Andrea “de Casallo”, oggi Casaglio, frazione di Cerreto d’Asti.
Nel 1008 il cenobio di Sant’Anastasio, pur essendo in possesso di un nucleo consistente di beni, è ricordato dal vescovo Alrico come “nimium sub paupertate degens”. Lo stato di povertà del monastero può essere imputabile a una cattiva amministrazione o forse al periodo storico immediatamente precedente, caratterizzato da devastazioni e insicurezza istituzionale.
Nello stesso anno, con la nomina di Alrico a vescovo di Asti, il complesso di Sant’Anastasio riceve la protezione vescovile sancita da un atto solenne, sottoscritto da tutto il clero
cattedrale della città. Si concretizza così lo stretto rapporto con il potere episcopale che caratterizzerà gran parte della storia del complesso situm infra civitatem astensem e, in quanto tale, unico monastero davvero urbano di Asti, profondamente radicato nel tessuto cittadino.
La scelta di Alrico, la cui nomina fu molto contestata, di presentarsi come benefattore e quasi rifondatore di Sant’Anastasio, è dovuta senz’altro al fatto che il monastero era non solo il più popolare, ma anche il più ricco e potente di Asti, nonostante il richiamo, forse solo di maniera, alla sua indigenza.
La badessa sibilla nel 1186 chiese la protezione del papa Urbano III
Fino alla prima metà del XII secolo Sant’Anastasio resta importante e radicato punto di equilibrio tra il potere vescovile e il Comune, ma nella seconda metà dello stesso si assiste, attraverso i documenti, a un allontanamento reciproco di Comune, Vescovato e Monastero, ognuno rappresentato da propri funzionari.
A questa situazione farà seguito un disinteresse da parte della chiesa vescovile per il monastero stesso. Nel 1186 la badessa Sibilla si rivolge direttamente a papa Urbano III, ottenendo la protezione papale per Sant’Anastasio e sottraendolo così al controllo diocesano. Le badesse continueranno per tutto il XIII secolo a cercare di mantenere i loro domini sotto la protezione papale, ma la Chiesa astigiana e il Comune assottiglieranno
sempre di più le dipendenze di Sant’Anastasio, fino a determinarne la fine del potere.

Il monastero soppresso nel 1802
La cripta diventa cantina, Secondo Pia ne fotografa le botti
Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento la chiesa romanica venne demolita per costruirne una nuova, in sintonia con i modelli culturali e architettonici propri della
Controriforma.
Chiesa e monastero continuarono a esistere fino al 1802, anno in cui furono soppressi in seguito alle leggi napoleoniche. Nel 1806 l’intero monastero venne privatizzato; nel 1835 fu acquistato dal Comune.
All’epoca l’edificio non mostrava evidenze medioevali; la cripta, adibita a cantina, fu riscoperta casualmente nel 1886 dall’avvocato Secondo Pia che la immortalò nella celebre immagine con le botti: «Della sua esistenza venni per caso a conoscenza, destinata a cantina dei custodi delle scuole soprastanti…».
La centralità del luogo ben si adattava a una riqualificazione dell’intero isolato per uso pubblico (soprattutto scuole) e così la chiesa già nel 1890 fu adibita a palestra.
Quando nel dicembre del 1906 l’ingegner Carlo Losio compilò il progetto del nuovo edificio scolastico, la cui realizzazione fu resa possibile dal consistente lascito del Conte Ottolenghi, le preesistenze archeologiche e storico- artistiche apparivano a tanti, e senz’altro ai progettisti e alla committenza, un fastidioso ostacolo. La proposta di riqualificazione dell’area prevedeva la demolizione dell’intero isolato «fabbricato lurido e deficiente» – secondo il sindaco Giuseppe Bocca – e l’edificazione di un complesso che doveva raccogliere tutte le scuole cittadine, «in modo sano e con una bella opera edilizia».
Niccola Gabiani, direttore dell’Ufficio d’Arte del Comune, ebbe un ruolo centrale nelle prime fasi di valorizzazione della cripta; fu consulente dell’ingegner Loiso nelle operazioni la demolizione nel 1907.

La demolizione nel 1907 dopo le discussioni su che cosa salvare dei resti precedenti
Probabilmente l’intervento di Gabiani, adombrato da un velo di ambiguità percepibile nelle
diverse prese di posizione del tecnico e dello studioso, farà sì che Carlo Loiso tuteli la cripta «che rimane così patrimonio artistico della nostra città, a disposizione dei visitatori».
Sul finire del 1907 iniziarono i lavori di demolizione della chiesa secentesca dopo aver
staccato gli affreschi in essa contenuti. Questi nuovi interventi riporteranno alla luce i resti della chiesa romanica, riaccendendo il dibattito sulla conservazione o meno di questi ultimi
ritrovamenti.
Dopo un lunga querelle che vide da un lato l’amministrazione, indifferente alle sollecitazioni degli organi di tutela, dall’altro figure di primo piano come Riccardo Brayda, Pietro Toesca, Alfredo d’Andrade discutere animatamente sul migliore modus operandi.
Scrive il Brayda nel 1905: «… Il fabbricato soprastante a questa cripta dovrà essere presto demolito per la costruzione di aule scolastiche; ed io un altro voto vi faccio, ed è che nelle
demolizioni sia non solo risparmiato questo tipo di basilica cristiana, ma che con cura speciale sia messo in condizione da poter essere facilmente visitato e studiato da coloro che amano il nostro patrimonio artistico» .
Nella primavera del 1908 il Sindaco di Asti, dichiarò «di non aver tralasciato di operare perché nell’esecuzione del nuovo edificio scolastico fossero conservati, senza alcuna deturpazione, i resti testè scoperti e le fondazioni della nuova costruzione vennero studiate
per modo che i ruderi sono e saranno conservati con la massima cura e con la medesima diligenza… onde gli studiosi delle patrie memorie e i visitatori possano in ogni tempo accedervi».
In ultimo, i resti della chiesa romanica furono vincolati secondo le procedure previste dalla Legge 185/1902, su impegno diretto di Gabiani. La Cripta e i resti romanici erano salvi.