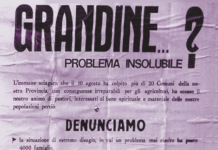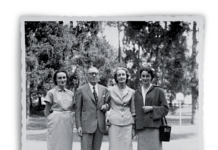Con il rischio di farsi mandare a “spané la meliga”
Fino alla metà degli Anni Sessanta il grano si mieteva nelle aie, sotto il sole cocente di fine giugno: le spighe venivano raccolte nei coev, i covoni, che poi si portavano a casa per sistemarli in cataste, burli, sotto i porticati fino all’arrivo della màchina da bati, la trebbiatrice, un “mostro” semovente generalmente di colore arancione. Trebbiare si dice infatti bati ‘l gran. Il trattore (spesso ancora un mitico “testa calda”) arrivava scoppiettando nell’aia e subito si sistemava el curiàs, una larga cinghia di cuoio (curàm, infatti la cintura dei pantaloni fatta di cuoio si chiama curèja) che andava dalla puleggia del trattore (il motore di tutta l’operazione) a quella della trebbiatrice, facendola girare e mettendo quindi in azione i suoi ingranaggi.
Ci volevano molti uomini attorno alla macchina, ognuno con una sua funzione. I covoni a uno a uno sparivano nel capace ventre della màchina, da cui uscivano separatamente: i chicchi, raccolti in sacchi che venivano riposti nel granaio; la paglia, pressata nella ambaladùra, l’imballatrice che sfornava le balle rettangolari, poi legate con il filo di ferro; l’avruchè, la pula, l’involucro che riveste il chicco. La trebbiatura era una festa, significava grano da vendere e grano per l’inverno; tutti collaboravano, la felicità per un raccolto abbondante faceva dimenticare il caldo torrido, la polvere, la fatica. E, di tanto in tanto, improvvisamente, tutto si bloccava, gli ingranaggi della trebbiatrice rallentavano il loro monotono canto e poi tacevano immobili. È drucàij el curiàs, era la spiegazione, cioè si era sfilata la grande cinghia che azionava tutto il processo.

La frase viene utilizzata ancora per commentare una vicenda (un affare, un progetto, una relazione amorosa) che si è fermata di colpo a causa di un incidente di percorso, di un black out. Anche il granturco (mèria) si raccoglieva a mano, riponendolo pannocchia dopo pannocchia in un sacco di iuta che si teneva su un fianco fissandolo a tracolla con una corda. Poi, la sera, il mais veniva sfogliato (sfujè a mèria) e successivamente sgranato, sgarnatà. Sgranare si dice anche spanè, e và a spanè da mèria, vai a sgranare del granturco, equivale a mandare qualcuno a quel paese, intendendo implicitamente “perchè quello è l’unico lavoro che sai fare”. E per sgranare il granoturco non ci vuole certo un grande ingegno. I chicchi venivano poi stesi al sole per farli essiccare, un lavoro lungo, perché ogni sera si ammucchiavano e si coprivano con teloni per proteggerli dall’umidità della notte e poi al mattino si tornava ad allargarli. Quando le aie non erano pavimentate, per non rischiare che si coprissero di terra si applicava sui cortili uno strato di sterco bovino (bisa) che diventava duro come il cemento: si diceva ambisè l’era, coprire l’aia di sterco bovino.
A chi non disponeva di abbastanza bisa, non restava altro da fare che tirè a mèria, lanciare il mais. I chicchi venivano raccolti con una pala di legno e poi lanciati contro un ostacolo, un muro oppure un telo, contro cui formavano il mucchio: nel breve “volo” la terra che si era appiccicata su di loro cadeva e il chicco era pulito come un anello, pulìd pej dn’anèl. La rievocazione delle vecchia trebbiatura è ancora presente in molte feste contadine. Indimenticabile l’allegria di Valentino Quaglia da Variglie che delle vecchie macchine per battere il grano era collezionista e sapeva farle rivivere.