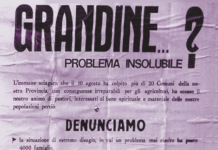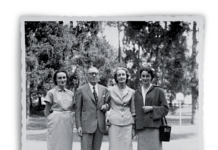Quegli anni fatati della vita. Rubo a Italo Calvino il titolo per sfogliare l’album dei ricordi dei cinque anni trascorsi sui banchi di legno del Liceo Classico “Vittorio Alfieri”. Un lungo viaggio negli Anni ’50 iniziato con le calzette corte di cotone, sostituite in quinta ginnasio dalle prime calze di nylon che, se le smagliavi, le portavi in corso Dante, dove in un piccolo negozio riuscivano a rimagliarle.
I maschi, in IV ginnasio, indossavano ancora i pantaloni alla zuava con lo sbuffo a metà polpaccio che metteva in evidenza i calzini corti e i piedi infilati in scarpe con la suola di gomma detta carro armato, che non esaltava certo il loro acerbo sex appeal. Arduo era anche per le ragazze essere attraenti, costrette com’erano a indossare mesti grembiuli neri. Una mia compagna di classe era molto ammirata per le forme generose che il grembiule, di lucido satin, e la luce che entrava dalle finestre mettevano maggiormente in risalto.
Io non possedevo le sue armi. Il mio modello era l’esile Audrey Hepburn: grandi occhi e sopracciglia “ad ali di gabbiano”. Una mattina la volli imitare. Bruciai un tappo di sughero e accentuai il disegno dell’arco sopraccigliare. Quando salii la scala per andare in classe incontrai la professoressa Poncini che mi guardò stupita e mi chiese cosa avessi fatto che “sembravo Mangiafuoco”. Mortificata fino alle lacrime corsi in bagno a cancellare il mio trucco.
I professori erano molto esigenti: la professoressa di matematica aveva la diabolica abitudine di chiamare alla cattedra estraendo a sorte. Veniva da Torino e, quando tardava a presentarsi, Franco Vergano si piazzava sulla porta dell’aula per scrutare il corridoio. Avevamo la speranza che il treno non solo fosse in ritardo, ma anche deragliato… invece, dopo un quarto d’ora, eccola sbucare, trafelata: grembiule nero, capelli intrecciati come quelli della Lucia manzoniana, il registro e l’odiato sacchettino tipo tombola, da cui speravo non uscisse il 4, il mio numero. E come non ricordare le difficili ore di greco di don Piazzino, l’alta cultura del professore di scienze Vaccaneo, le ore di italiano e latino del professor Baracco, quelle di storia e filosofia del professor Barberis.

Il suono della campanella giungeva a liberarci a fine mattina. Allora si sciamava per corso Alfieri, si sentiva la voce alta di Primo lo strillone che vendeva i giornali. Poi si superava l’unico semaforo esistente in città, all’angolo con via Gobetti. Subito dopo giravo con un mio compagno di classe e di innocente flirt in piazza Medici. La gioia di stare insieme finiva a pochi passi da piazza Dante.
Li dovevamo lasciarci: appoggiata a un cuscino di velluto, la nonna di Giorgio e Paolo Conte era solita affacciarsi a quell’ora dal suo terrazzo: avrebbe subito detto a mia madre che ero accompagnata da un ragazzo. Oggi la cosa fa sorridere ma a quei tempi di austera morale, aveva un peso.
Con riconoscenza ricordo il professor Cazzani, un preside eccezionale che ci faceva recitare le tragedie dell’Alfieri, organizzava viaggi a Milano per la Fiera campionaria o per assistere agli spettacoli del Piccolo Teatro. Il ricordo più struggente rimane tuttora la lunga passeggiata a Viatosto l’ultimo giorno di scuola, con noi studenti della terza liceo: così, solo per camminare insieme un’ultima volta, raggiungere il piazzale della chiesetta, asciugarsi il sudore, bere alla fontanella e tornare indietro. Un modo tutto suo per dirci «addio ragazzi, buona fortuna nella vita.»